Davide Chierichetti, Annibale Damiano e Lorenzo Dolfi
“Se dapprima l’europeo era venuto nei mari d’oriente col volto atteggiato alla più umile devozione verso il figlio del Cielo e con l’animo pieno di tutto il rispetto per le idee, i metodi, le tradizioni dei suoi sudditi, non aveva poi tardato a togliersi la maschera e ad usare tutt’altro sistema non escluso quello della forza per raggiungere i suoi scopi” (Tosti, A. 1926; La spedizione italiana in Cina 1900-1901).
Nel 1866, con la firma del trattato commerciale del 4 novembre, iniziarono i rapporti diplomatici tra il Regno d’Italia e la Cina imperiale della dinastia Quing, assicurando all’Italia tutti i diritti di cui già godevano le altre potenze europee. Tuttavia, il volume degli scambi commerciali tra i due paesi era decisamente modesto: basti pensare che gli italiani residenti nei porti aperti erano 23 (17 solo a Shangai) e lavoravano soprattutto in qualità di allevatori di bachi da seta. Il trattato, firmato su incarico del Presidente del Consiglio La Marmora dal comandante della nave “Magenta” tale Vittorio Arminjon, aveva l’obiettivo di agevolare il commercio italiano sulle coste cinesi. Ciò, tuttavia, non si concretizzò: in primo luogo per la mancanza di una linea di navigazione diretta in Estremo Oriente; in secondo luogo per l’inadeguatezza e la scarsa preparazione del corpo diplomatico in Cina (tra il 1870 e il 1890 la rappresentanza italiana disertò quasi tutti gli incontri ufficiali); il terzo e ultimo motivo fu la trascuratezza delle usanze e delle tradizioni locali da parte degli avventori di nazionalità italiana. Nemmeno le attività commerciali private ebbero successo, a causa dell’elevato costo delle merci italiane, anche se l’importazione di seta dalla Cina vide un incremento.
La decisione presa dal governo italiano di non appoggiare immediatamente nel primo conflitto sino-giapponese del 1894 la dinastia Quing, nonostante le richieste di quest’ultima, incrinò i rapporti diplomatici tra i due Paesi. Al termine delle ostilità la Cina subì ingenti perdite territoriali, e fu costretta a cedere parte della sua sovranità a Francia, Germania, Russia e Gran Bretagna, le quali già erano in possesso di alcune concessioni in aree ritenute strategiche; anche l’Italia avanzò una richiesta formale, per la Baia di San Mun. Nel frattempo, in Cina, una recrudescenza della xenofobia e un serpeggiante misoneismo[1] sfociarono in moti di protesta sempre più accesi, tanto che nel giugno del 1900 la tensione culminò in un assedio al Quartiere delle Legazioni a Pechino da parte dei Boxers, scatenando attriti in tutta la Cina settentrionale.
I Boxers (“pugni di giustizia e concordia”), società segreta che raggruppava contadini privi di terra, carrettieri,
![Service Géographique de l’Armée, Théâtre des opérations en Chine: environs de Pékin, [s.d.]. La carta indica i principali scenari delle operazioni di guerra contro i Boxers, tra il 1900 e il 1901](http://societageografica.net/wp/wp-content/uploads/2020/09/RR_2_SGI_Théâtre-des-opérations_1870-300x217.jpg)
Service Géographique de l’Armée, Théâtre des opérations en Chine: environs de Pékin, [s.d.]. La carta indica i principali scenari delle operazioni di guerra contro i Boxers, tra il 1900 e il 1901
artigiani, portatori di sedie, piccoli funzionari e soldati in congedo, non agirono da soli ma furono sostenuti anche da reparti dell’esercito regolare con il tacito consenso dell’Imperatore Tsu-hsi. La particolare efferatezza con la quale questi agirono contro missionari e cinesi convertiti al cristianesimo, fece sì che venissero immediatamente demonizzati dagli organi di stampa internazionale. Nessuno si preoccupò di individuare le cause remote delle violenze in atto: a nessuno ancora era venuto in mente che i Boxers esprimessero un dissenso nei confronti della crescente influenza coloniale sui costumi e i valori del loro popolo. Essi non vedevano favorevolmente l’ampliamento della rete ferroviaria, la costruzione delle linee telegrafiche, la comparsa delle navi a vapore, tutte novità che nell’immediato toglievano loro lavoro e opportunità. Così partì alla volta della Cina un contingente internazionale composto da reparti regolari giapponesi, russi, inglesi, statunitensi, tedeschi, francesi, austriaci e italiani, per un ammontare complessivo di circa 20.000 uomini. L’obiettivo era trarre in salvo i 473 civili stranieri che da giugno erano assediati dai Boxers nel Quartiere delle Legazioni di Pechino. L’auspicio dell’Italia, intervenendo questa volta, era quello di potersi sedere al tavolo delle trattative al momento della vittoria, sperando di vedersi riconosciuto un qualche diritto territoriale.
A Pechino, dove fu lanciato l’attacco finale e liberato il Quartiere delle Legazioni, ebbero luogo un saccheggio e una carneficina sistematici e il tutto continuò per diversi mesi, con i contingenti delle varie nazioni che si accusavano vicendevolmente di rapacità. Al termine delle operazioni belliche, con l’accordo del 7 giugno 1902, la Cina riconobbe all’Italia l’indennizzo per le spese sostenute e il settlement di Tientsin (l’odierna Tianjin), cioè la perpetua proprietà di un terreno di quasi 46 chilometri quadrati e con 17.000 abitanti posto nei sobborghi della città cinese e compreso tra le concessioni russa e austriaca[2].
Si trattava di un territorio scarsamente popolato da stranieri, specie italiani, tanto che in un primo momento si pensò di affidare la gestione del nuovo possedimento ad una compagnia commerciale formata da alcuni imprenditori italiani residenti in Cina, che avrebbero dovuto provvedere alla bonifica dell’area. Questa, in possesso del Regno d’Italia, era costituita da ampi lacerti di terreno paludoso e malarico, che richiedevano ingenti interventi. Il governo italiano, che pagava un canone di 2800 lire oro, decise alla fine di porre il possedimento sotto il controllo diretto dello Stato e nominò un Commissario Regio, il console Vincenzo Fileti, il quale avviò le prime opere di riqualificazione. I principali introiti erano costituiti dalle tasse versate dai residenti locali e la sicurezza e l’ordine pubblico erano garantiti da un reparto di Carabinieri coadiuvato da milizie ausiliarie autoctone. La carenza di fondi per avviare le bonifiche e la pressochè totale assenza di cittadini italiani si tradusse in una fase di stallo per la concessione, interrotta solo nel 1912 dalla Cassa Depositi e Prestiti con un finanziamento di 400 mila lire. Principale sostenitore dello sviluppo della concessione fu il Ministro degli Esteri Antonino di San Giuliano, convinto che l’espansione italiana in Cina avrebbe incrementato il prestigio dell’Italia. Iniziarono in tal modo i lavori per la costruzione dell’Ospedale, il primo costruito nella città secondo criteri moderni, di una caserma e del palazzo della Municipalità Italiana; in questo modo prese forma un quartiere residenziale costituito da villini e abitazioni che fondevano l’architettura italiana con gli stilemi classici dell’arte e dell’architettura cinesi[3].
Alla fine della Prima Guerra Mondiale, visti i disordini esplosi in Cina a seguito della decisione dei Nazionalisti di annettere le regioni settentrionali, le potenze Occidentali furono messe in allarme e anche il Governo italiano, per evitare problemi di ordine pubblico, decise di inviare un contingente militare per presidiare la concessione[4]. Nel 1927 Galeazzo Ciano venne inviato a Pechino con l’incarico di Segretario della Legazione. Egli lavorò per acquisire sempre maggiore credibilità negli ambienti ultranazionalisti cinesi sino ad ottenere la nomina, da parte del governo, di Ministro Plenipotenziario Italiano in Cina (1932). In virtù di questi buoni uffici stabiliti con i politici di Nanchino e dell’ammirazione nutrita dal leader nazionalista Chiang Kai Shek nei confronti dell’ideologia fascista, iniziò una nuova fase delle relazioni diplomatiche tra Italia e Cina. Nel 1932, ad esempio, fu fondata la Lega italo-cinese con il duplice scopo di favorire la conoscenza della cultura cinese in Italia e di monitorare l’adesione dei delegati dell’Estremo Oriente ai valori fascisti. Le relazioni sino-italiane conobbero il loro apice tra il 1934 e il 1935, quando venne inaugurata la prima ambasciata italiana in Cina. Queste, invero, incorsero in un rapido declino, imputabile soprattutto all’incertezza della politica estera italiana, pericolosamente oscillante tra posizioni talvolta affini a quelle cinesi, altre volte a quelle giapponesi.
La concessione italiana di Tientsin non sembrava ancora risentire dei complessi e precari equilibri interni della Cina.
Nel 1936 vennero censiti 7.953 abitanti, dei quali 358 di nazionalità italiana[5]. La popolazione, composta principalmente da ricchi cinesi e diplomatici internazionali che vi erano andati a risiedere, fece della concessione un quartiere di élite. La concessione di Tientsin dal punto di vista italiano veniva ora considerata una colonia a tutti gli effetti, nonostante da una prospettiva giuridica non fosse tale. Il territorio, infatti, era stato solamente affittato dal Governo italiano e questo ne condizionò anche il sistema di governance adottato per la gestione amministrativa. Il governo locale accolse sovente anche la partecipazione della popolazione autoctona ai processi decisionali, in netto contrasto con quanto accadeva in altri possedimenti.
Il 1937 vide la definitiva rottura tra il Regime fascista e la Cina nazionalista, quando l’Italia riconobbe formalmente il Manchukuò[6] aprendo un proprio consolato presso Mukden. L’atteggiamento italiano rimarrà tuttavia ambiguo: fu senza dubbio sposata una politica filo-nipponica ma si continuarono a fornire armi ai nazionalisti cinesi che nel frattempo avevano formato un fronte comune con i comunisti contro l’invasore.
Allo scoppio della seconda guerra sino-giapponese, nel 1937, le armate nipponiche arrivarono ad assediare anche Tientsin, bloccando tutti gli ingressi alle concessioni internazionali. Nel 1940 venne fondato un governo collaborazionista con sede a Nanchino, noto come il Governo Nazionale della Cina, riorganizzato con lo scopo di condurre delle trattative con il Giappone e proporre in tal modo una risoluzione del conflitto e di lì a poco fu imposta la cessione alla Cina dei diritti di extraterritorialità da parte di tutte le potenze straniere.
A questo punto il Regime fascista avviò delle trattative con Nanchino siglando, nel 1943, un trattato con cui si impegnava a restituire alla Cina le opere pubbliche e la sede italiana nel quartiere delle Legazioni a Pechino, ottenendo dal Governo cinese dei diritti di extraterritorialità sull’ambasciata italiana e sulle proprietà possedute dagli italiani.
Furono dunque avviate le trattative, seppur con molta lentezza, per la rinuncia alla concessione da parte dell’Italia. Queste proseguirono fino all’estate del ’43, quando venne stabilita la restituzione alla Cina del quartiere di Tientsin.
Nel 1945, il ripristino delle relazioni internazionali tra il governo guidato da De Gasperi e la Cina di Chiang Kai Shek consentì di avviare nuovamente le trattative per la concessione di Tientsin, interrotte bruscamente a causa dell’invasione della stessa da parte dei giapponesi all’indomani dell’armistizio dell’8 settembre del 1943. Si giunse ad un accordo solo nell’agosto 1946, con la rinuncia definitiva da parte di Roma ai benefici concessi dalla Cina nel 1901, restituendo il territorio posseduto a Tientsin e i diritti di amministrazione negli insediamenti internazionali di Shangai e Amoy. L’avventura coloniale italiana in Estremo Oriente poteva dirsi definitivamente conclusa.
In conclusione, si può affermare che la concessione italiana di Tientsin non divenne mai nevralgica per gli investimenti italiani in Cina[7]; tuttavia, le autorità italiane la consideravano un prezioso avamposto in grado di agevolare la diffusione della cultura italiana e fascista in Cina mediante manufatti architettonici (ancora oggi visibili) e tentativi di permeazione del tessuto sociale cinese. Intenzioni che non corrisposero a fatti concreti.
[1] L’Imperatore Cixi, ripreso il potere, fu costretto ad abrogare tutte le riforme progressiste ispirate alla cultura politica occidentale.
[2] L’area era stata preventivamente occupata dal contingente italiano con l’obiettivo di richiederla a Pechino, nonostante fosse in vigore un accordo che impediva ulteriori richieste territoriali alla Cina.
[3] Il nuovo Regolamento Edilizio del 1924 vietò gli stili architettonici ibridi.
[4] La situazione in Cina era precipitata a seguito della caduta della dinastia Quing.
[5] Questi oramai in graduale calo rispetto ai due censimenti precedenti.
[6] Il Manchukuò fu uno stato fantoccio creato dal Giappone in Manciuria nel 1932, con il sostegno degli ufficiali della deposta dinastia Quing.
[7] Il ruolo fu sempre mantenuto da Shangai.
Bibliografia
Del Boca, A. (2005); Italiani, brava gente?; Neri Pozza editore, Vicenza.
Di Meo, A. (2015); Tientsin. La concessione italiana. Storia delle relazioni tra Italia e Cina (1866-1947); Ginevra Bentivoglio Editoria, Roma.
Rostagni, C. (2012); Italia e Cina: un secolo di relazioni; Italogramma, Vol. 2 (2012), “Identità italiana e civiltà globale all’inizio del ventunesimo secolo”, pp. 43-53.
Tosti, A. (1926); La spedizione italiana in Cina: 1900-1901; Provveditorato generale dello Stato, Roma.













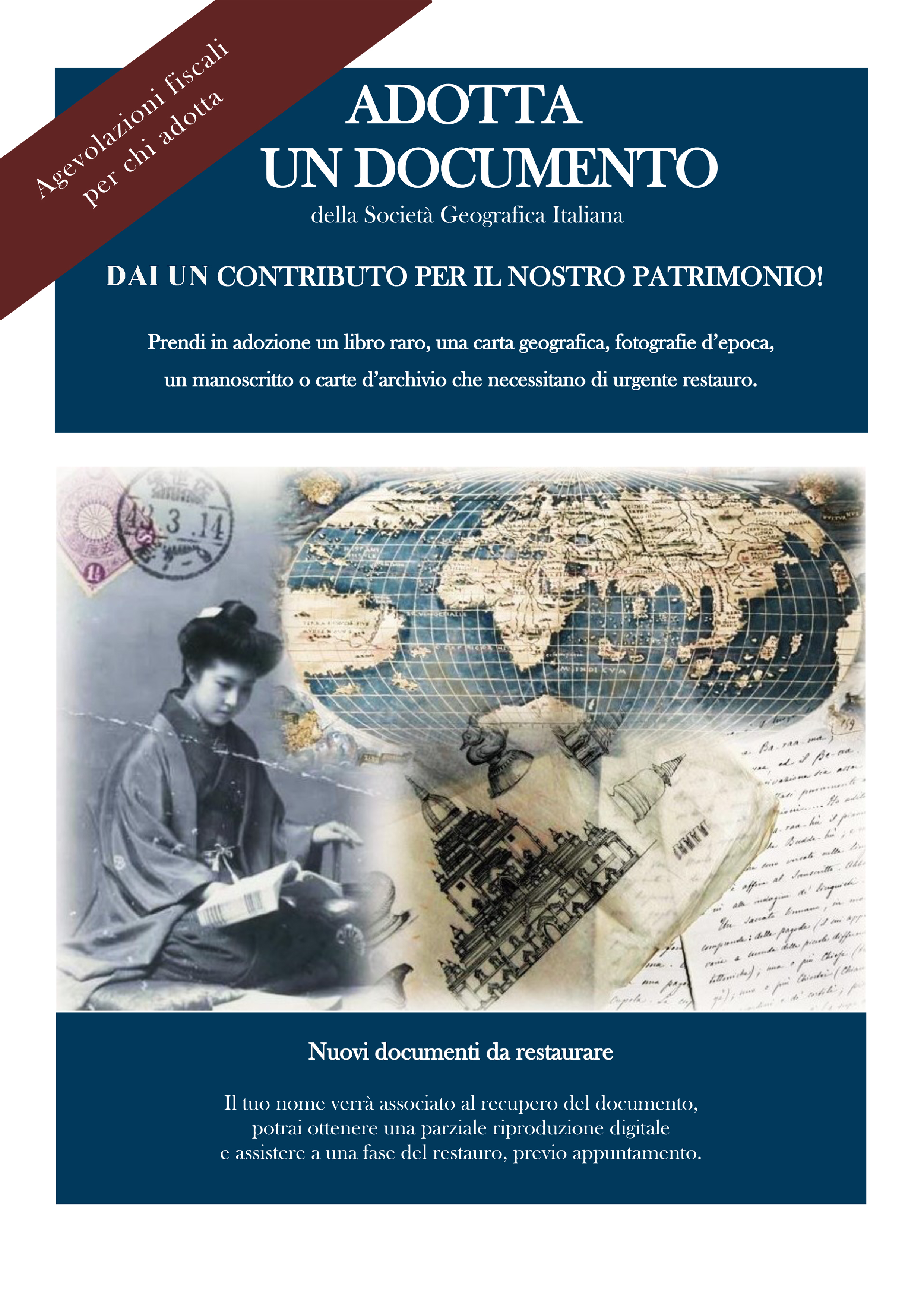

![Pianta della concessione italiana di Tientsin, [s.d.]](http://societageografica.net/wp/wp-content/uploads/2020/09/RR_1_SGI_Tien-Tsin-pianta-250x300.jpg)





